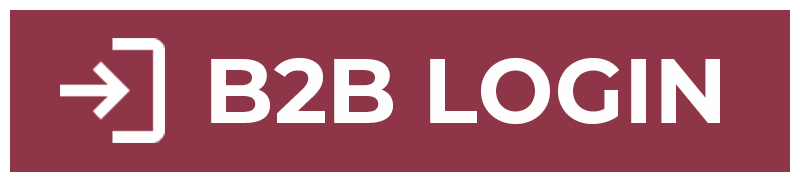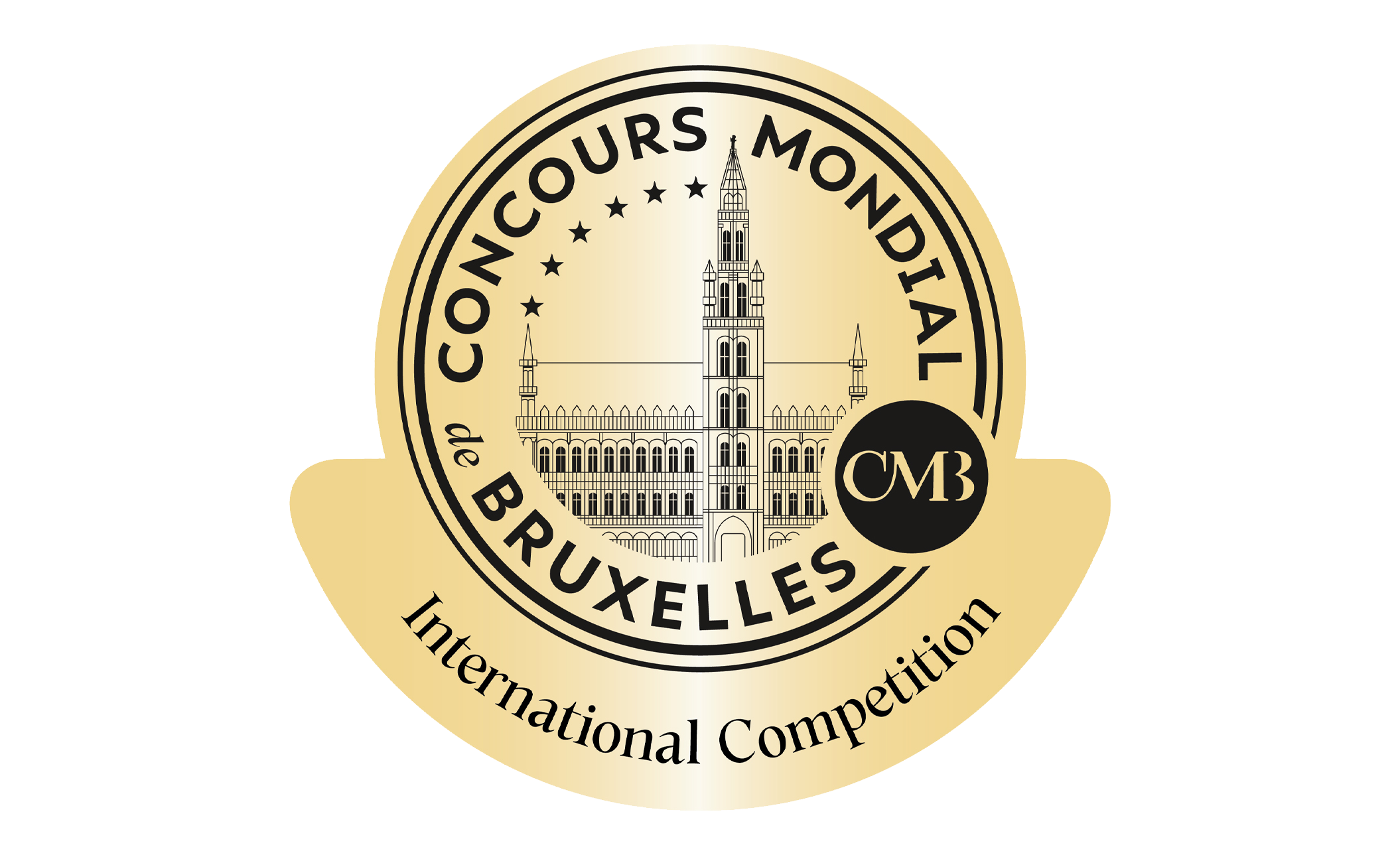Chianti, un’invenzione della natura e della cultura Toscana
La zona di produzione del Chianti è costituita da territori delimitati per legge, che si trovano nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Questo ambiente è caratterizzato da un sistema collinare a grandi terrazze con vallate attraversate da ?umi.
L’origine del vino Chianti si perde nei secoli, ma ha avuto la sua consacrazione nell’800. La prima delimitazione uf?ciale del territorio e delle modalità di produzione risale al 1932 ed ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, in cui si ?ssano le sue caratteristiche in un apposito Disciplinare di Produzione.
La Denominazione “Chianti” può essere integrata con le menzioni aggiuntive Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Ru?na e Montespertoli, corrispondenti, le prime, alle sottozone geogra?che, contemplate dalla prima delimitazione del territorio, stabilita con D.M. 31 luglio 1932, mentre l’ultima, Montespertoli, è stata riconosciuta con Decreto 8 settembre 1997. In tali zone speci?che, sono previste per il vino modalità produttive più restrittive e requisiti particolari.
Interessante notare il recupero della tipologia “Superiore”, con più alte caratteristiche e che riguarda potenzialmente tutta la zona dei vini Chianti.
I vitigni fondamentali che concorrono alla formazione del vigneto Chianti sono i seguenti: Sangiovese minimo 70%, complementari ?no al 30%, con un massimo per i vitigni bianchi del 10% e del 15% per i vitigni Cabernet. Le rese massime di uva per ettaro, per gli impianti ad alta densità, sono di 11 tonnellate per il Chianti, 9,5 tonnellate per Colli Aretini, Colline Pisane, Montalbano, Rù?na, Montespertoli e Chianti Superiore, 9 tonnellate per Colli Fiorentini e Colli Senesi.
Il Chianti è di colore rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento, di sapore armonico, sapido, leggermente tannico, con odore intenso, vinoso, anche con sentori di mammola.
Può essere consumato, per qualche tipologia, come vino giovane, fresco e gradevole al palato, ma è ben nota anche, per alcune zone, la sua vocazione ad un medio e lungo invecchiamento, con cui matura colore, profumo e sapore inconfondibili.
Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 settembre 2012 è stato concesso il riconoscimento e l’incarico per la valorizzazione, promozione e vigilanza anche sulle denominazioni Vin Santo del Chianti e Colli dell’Etruria Centrale.
La denominazione “Colli dell’Etruria Centrale” si pone in af?ancamento alla D.O.C.G. Chianti consentendo la produzione nella stessa zona di vini di qualità diversi dal Chianti prevedendo oltre alla tipologia rosso, il bianco, il rosato, il novello e il Vin Santo.
Il riconoscimento della denominazione “Vin Santo del Chianti”, con la possibilità di usare le varie sottozone, segna un’importante tappa per la valorizzazione di questo prodotto che tanto rappresenta per le tradizioni e le capacità produttive nella zona del Chianti e per il quale il Consorzio si è a lungo battuto.

Il Consorzio Vino Chianti si è costituito nel 1927 ad opera di un gruppo di viticoltori delle province di Firenze, Siena, Arezzo e Pistoia, allargando successivamente la sua operatività a tutta la zona di produzione, riconosciuta dal Disciplinare del 1967, poi recepita nella Denominazione di Origine Controllata e Garantita riconosciuta nel 1984 e aggiornata, per ultimo, con decreto del 19 giugno 2009.
Oltre tremila produttori, che interessano più di 15.500 ettari di vigneto per oltre
800.000 ettolitri di Chianti delle varie zone e tipologie, sono tutelati dal Consorzio che, per la sua rappresentatività, ha ottenuto il riconoscimento “ERGA OMNES” con conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla D.O.C.G. “Chianti” con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 03 Settembre 2012, rinnovato con Decreto Ministeriale del Settembre 2015.
Le denominazioni del Consorzio Chianti sono:
- Chianti DOCG
- Chianti riserva DOCG
- Chianti Superiore DOCG
- Colli dell’Etruria Centrale DOC
- Vin Santo del Chianti DOC
- Vin Santo del Chianti Riserva DOC
- Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice DOC
- Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice Riserva DOC
Consorzio Vino Chianti